|
 Il Comune
di Livinallongo del Col di Lana (Fodóm in ladino,
Buchenstein in tedesco) è situato in Italia, nella
provincia di Belluno della Regione Veneto.
Il Comune
di Livinallongo del Col di Lana (Fodóm in ladino,
Buchenstein in tedesco) è situato in Italia, nella
provincia di Belluno della Regione Veneto.
Si tratta di un "comune sparso" in quanto sede comunale è la frazione Pieve di
Livinallongo.
Fa parte del comprensorio della Ladinia.
Gli abitanti sono
1.339
Altitudine 1.475 sul livello del mare.
Il territorio del Comune di Livinallongo del Col di Lana (100 Kmq) presenta la
sua valle solcata dal torrente
Cordevole che prende origine dal
Passo Pordoi,
sul versante orientale, fra il
gruppo del Sella e la catena del Padon.
 Il territorio di Livinallongo è limitato quasi interamente da confini naturali,
e precisamente: ad est le creste del Nuvolao lo dividono dalla Comunità di
Ampezzo, mentre i dirupi del Settsass e le lunghe giogaie del Pralongié dalla
Valle di S. Cassiano; ad ovest le alture di Sommamont e di Forcelle lo separano
dalla Valle di Corvara, mentre il gruppo del Sella ed il Sass Beccè da Gardena
e Fassa; a sud le lunghe vette della catena del Padon dalla Valle di Penia e
della Pettorina ed ad est il rivo di Davedino.
Il territorio di Livinallongo è limitato quasi interamente da confini naturali,
e precisamente: ad est le creste del Nuvolao lo dividono dalla Comunità di
Ampezzo, mentre i dirupi del Settsass e le lunghe giogaie del Pralongié dalla
Valle di S. Cassiano; ad ovest le alture di Sommamont e di Forcelle lo separano
dalla Valle di Corvara, mentre il gruppo del Sella ed il Sass Beccè da Gardena
e Fassa; a sud le lunghe vette della catena del Padon dalla Valle di Penia e
della Pettorina ed ad est il rivo di Davedino.
Il suo territorio presenta una caratteristica del paesaggio dolomitico, dai
versanti ora rivestiti da grandi abetaie, contratti e terrazze ben coltivati, o
scoscesi, ora con le alte dorsali stendentesi in verdi praterie e grandi
pascoli, interrotte da massicci rocciosi.
 |
I Romani giunsero in questo territorio già nel
III secolo a.C., ma ci vollero anni per assoggettare completamente le fiere
popolazioni retiche
che abitavano in quest'area.
Nel 15 a.C. i
 Romani
sotto il comando di
Druso e
Tiberio occuparono il territorio alpino,
spingendosi fino alle rive del Danubio. La parte settentrionale dell'odierno
Alto Adige venne successivamente divisa fra le due province
Rezia (Raetia prima e Raetia secunda)
e
Norico (Noricum), mentre quella
meridionale che includeva la Val d'Adige fino all'altezza di Merano venne
inclusa nella
Regio X Venetia et Histria. Romani
sotto il comando di
Druso e
Tiberio occuparono il territorio alpino,
spingendosi fino alle rive del Danubio. La parte settentrionale dell'odierno
Alto Adige venne successivamente divisa fra le due province
Rezia (Raetia prima e Raetia secunda)
e
Norico (Noricum), mentre quella
meridionale che includeva la Val d'Adige fino all'altezza di Merano venne
inclusa nella
Regio X Venetia et Histria.
Il periodo romano si protrasse per cinque secoli e lasciò profonde
tracce nella regione che fu fortemente latinizzata.
 Dopo le
invasioni barbariche, il territorio fu soggetto ai
Longobardi
e quindi ai
Franchi, fondatori del
Sacro Romano Impero. Con l'imperatore
Ottone I di Sassonia la zona dolomitica fu
ricompresa nella
Marca di Verona, a sua volta dipendente dal
ducato di Baviera prima e dal 975, sotto il controllo del Ducato di Carinzia.
Dopo le
invasioni barbariche, il territorio fu soggetto ai
Longobardi
e quindi ai
Franchi, fondatori del
Sacro Romano Impero. Con l'imperatore
Ottone I di Sassonia la zona dolomitica fu
ricompresa nella
Marca di Verona, a sua volta dipendente dal
ducato di Baviera prima e dal 975, sotto il controllo del Ducato di Carinzia.
Qualcuno sostiene che a questo periodo risalga il
Castello di Andraz situato nel Comune di
Livinallongo.
Del 1005 è un
documento che definisce i confini della contea della
Val
Pusteria; forse, per la prima volta, vi sono citate alcune località
livinellesi.
Attorno al 1141 fu
fondata l'abbazia
di Novacella con possedimenti anche su Livinallongo: uno scritto del
1142 documenta la
donazione al convento del mansus Puchberc qui dicitur Wersil, un maso
identificabile con Fursil, nella zona di
Colle Santa Lucia. È il primo documento che cita con sicurezza la zona.
Interessante notare che per prima viene citata l'area di Colle Santa Lucia, in
posizione più marginale rispetto a Livinallongo: è probabile che i vescovi si
fossero preoccupati di colonizzare per primi i territori di confine.
Nella primavera del 1796
Napoleone Bonaparte aveva passato con una forte armata
le Alpi ed aveva battuto gli austriaci nella pianura Padana, conquistando con
una guerra-lampo la Lombardia.
Mentre Napoleone proseguiva con il grosso dell’esercito direttamente alla volta
di Vienna, un corpo del suo esercito risaliva la
valle dell’Adige per sbarrare
la strada ai tedeschi che per la valle stessa potevano attaccarlo alle spalle.
Nel marzo del 1797 i francesi erano arrivati nell’Alta Valle dell’Isarco. E di
fronte al grave pericolo dell’invasione erano stati inviati rinforzi ed erano
stati richiamati gli uomini validi del Tirolo per respingere il nemico, che fu
fermato a Vipiteno e fu costretto a retrocedere a Bressanone. Ma i francesi
contrattaccarono a Spinges, piccolo gruppo di case sopra a Sciaves e Rio di
Pusteria.
 Il 2 aprile, alle 2 del pomeriggio, i valligiani dopo una strenua resistenza
stavano ormai ripiegando, quando una ragazza che era in servizio presso un
contadino di Spinges, uscì da una stalla, saltò oltre il muro del cimitero e
davanti alla porta della chiesa, armata di una forca, atterrò (forse spaventò
solo) alcuni soldati francesi, gli altri volsero in fuga. Quella ragazza era
Catarina Lanz, nata a Pian di Marebbe 26 anni prima, il 21
settembre 1771, in casa di un povero contadino che
l’aveva mandata come serva in Pusteria, appena quattordicenne, ad imparare il
tedesco. La Lanz, dopo lo scontro di cui fu eroina, si fermò a Bressanone e a
Spinges per 14 anni. Di lì andò serva di don Pietro Alton a Colle Santa Lucia,
poi, dal 1851 al 1854, come cuoca presso il curato Giovanni Maneschg a Andraz.
Il 2 aprile, alle 2 del pomeriggio, i valligiani dopo una strenua resistenza
stavano ormai ripiegando, quando una ragazza che era in servizio presso un
contadino di Spinges, uscì da una stalla, saltò oltre il muro del cimitero e
davanti alla porta della chiesa, armata di una forca, atterrò (forse spaventò
solo) alcuni soldati francesi, gli altri volsero in fuga. Quella ragazza era
Catarina Lanz, nata a Pian di Marebbe 26 anni prima, il 21
settembre 1771, in casa di un povero contadino che
l’aveva mandata come serva in Pusteria, appena quattordicenne, ad imparare il
tedesco. La Lanz, dopo lo scontro di cui fu eroina, si fermò a Bressanone e a
Spinges per 14 anni. Di lì andò serva di don Pietro Alton a Colle Santa Lucia,
poi, dal 1851 al 1854, come cuoca presso il curato Giovanni Maneschg a Andraz.
L’8 luglio del 1854 morì, a 83 anni, e fu sepolta nel cimitero di Pieve di
Livinallongo con gli onori militari.
Un monumento fu inaugurato in suo onore a Pieve di Livinallongo il 22
luglio 1912; questo, nel 1915, durante la grande guerra, fu portato a Corvara,
poi al Museo di Rovereto, di dove nel 1967 tornò nella piazza di Pieve.
Tornando alle vicende storiche di Livinallongo, occorre precisare
che nel
1809 preoccupante divenne la rivolta contro i francesi, odiati
perché offendevano la religione, e contro i bavaresi loro alleati, che si erano
dimostrati duri oppressori, Napoleone decise di inviare contro i ribelli due
corpi militari, in prevalenza di soldati italiani. Uno doveva entrare in Alto
Adige dal Trentino, mentre l’altro dal Bellunese. Fu quest’ultimo a trovare una
debole resistenza, che poteva finire in massacro: il 2 novembre, al confine
veneto, 13 fra livinellesi e badioti presero a fucilate il corpo francese che
saliva da Agordo, al comando del generale Peyri, ma non successe nulla: il
capitano Canins, che comandava i soldati tirolesi, ordinò subito di deporre le
armi, ed il generale francese, occupato il paese, si comportò amichevolmente.
Nel 1810 Livinallongo formò l’ultimo confine del
Dipartimento del Piave, confine
che correva sulla cresta settentrionale dei monti. Caprile, con la parrocchia di
Pieve di Livinallongo, venne aggregata alla diocesi di Belluno, e vi restò anche
quando nel 1814 con le chiese di Colle e di Arabba fu restituita a Bressanone.
Alla caduta di Napoleone, nel 1815, dopo aver fatto parte della Baviera e del
Regno d’Italia, Livinallongo
fu riannesso all’Austria e vi restò fino al termine della
Grande Guerra.
Nella mobilitazione generale del 2 agosto 1914 i soldati fodomi vengono chiamati
alle armi ed inviati sul fronte orientale (russo). Il 24 maggio 1915, alla
dichiarazione di guerra italiana, si costituisce trasversalmente lungo il
territorio montagnoso del Comune di Livinallongo la linea del fronte: Marmolada, Mesola, Padon, Foppa, Col di Roda, Sief, Col di Lana, Setsass, Sasso
di Stria, Lagazuoi.
 |
Alla fine di maggio e nel mese di giugno 1915 le truppe italiane avanzano
da Caprile ed occupano Colle Santa Lucia, Monte Pore, Larzonei, Andraz, Collaz,
Foram, Salesei.
Il comando austriaco ordina l’evacuazione dei paesi e trasferisce il monumento
di Caterina Lanz (inaugurato nel 1912) nel cimitero di Corvara.
La popolazione della parte bassa della valle va profuga a Colle Santa Lucia
oppure viene condotta dalle autorità italiane in Piemonte, Toscana, Abruzzi,
Marche. La popolazione della parte alta della valle va profuga in Val Badia, in
Val Punteria, perfino in Boemia.
Pieve, ormai evacuata, fu occupata dalle truppe italiane
nella notte tra il 25 e 27 luglio 1915.
Il
forte La Corte risponde al fuoco delle artiglierie italiane e bombarda il
territorio occupato: Pieve viene bombardata il 18 agosto 1915. Poco dopo il
forte viene abbandonato ed il comando si trasferisce sul Col di Roda.
Il 26 agosto 1915 gli italiani, per risposta, bombardarono Arabba, Varda e
Cherz.
Nel settembre 1915 Livinallongo è ormai deserta e distrutta, soltanto
soldati italiani si aggirano per i villaggi e l’obiettivo del fronte si
concentra sul Col di Lana. Ma già erano caduti 6.400 soldati italiani e 1.600
austrungarici.
L'ottobre 1915, altrettanto cruento, permise all'esercito italiano di
conqustare i capisaldi (Fortino austriaco, Cappello di Napoleone e Panettone)
dei tre costoni (Castello, Agai e Salesei) che puntano alla Cima Lana,
rispettivamente il 29, 26 e 22 ottobre.
Queste conquiste permesero all'esercito italiano di
accamparsi proprio al di sotto della Cima e in realtà il 7 dicembre 1915
l'esercito italiano conquistò, ma subito perse, la vetta del Col di Lana;
 |
| La
"dolce Conca" sede delle baracche italiane, poste proprio
sotto Cima Lana, confrontata con la situazione di oggi |
Per conquistare la Cima occorse la famosa
mina del Col di Lana
che venne fatta saltare, per
ordine del maggiore Mezzetti, dal tenente
Gelasio Caetani, duca di Sermoneta,
alle ore 22.35 del 17 aprile 1916. Lo scoppio della Mina provocò un cratere di
30 m x 65 m e profondo 15 m: in questa operazione 110 soldati austriaci rimangono uccisi
e 170 vengono fatti prigionieri nelle caverne.
Dovunque durante il conflitto vengono sepolti i caduti dei due fronti.
Vengono improvvisati cimiteri italiani a Pian di Salesei,
Andraz, Castello; e
austroungarici a Col di Roda, Valiate, Val Parola (due) e Passo Pordoi.
|
 |
Nel 1938 verrà costruito il
Sacrario di Pian di Salesei che custodisce le
spoglie di 4.700 caduti ignoti, 704 noti tra cui 19 austro-ungarici.
Nel 1935 è stata inaugurata la
cappella del Col di Lana, costruita in onore dei caduti
della Prima Guerra Mondiale, senza distinzione di nazionalità.
La Cappella fu costruita su proposta di Gelasio Caetani
(l'ideatore della "Mina") che allora era presidente del Comitato Nazionale per
le onoranze dei Caduti del Col di Lana.
Nel 2006 la Cappella è stata rifatta ex novo e
perfettamente identica alla precedente, alla quale era stato, a suo tempo,
sostituito il campanile con uno più austero.
Nel 2012 all'interno della Cappellina è stata collocata, da un
soldato italiano ed uno austriaco, una piccola statua dei
S. Ubaldo, patrono di Gubbio e "Santo della
Riconciliazione" al termine di una cerimonia religiosa
presenziata dal Vescovo di Gubbio.
Il monumento ai caduti sulla piazza 7 novembre 1918 a Pieve
riporta i nomi di 135 caduti e dispersi fodomi della Grande Guerra
ed é un numero altissimo tenendo conto del numero di abitanti.
A cominciare dalla primavera del 1918 i profughi fodomi ritornano nella valle
abbandonata dai militari e cominciano l’opera di ricostruzione del paese,
abitando provvisoriamente nelle baracche militari e nelle poche case risparmiate
dai bombardamenti. La ricostruzione viene aiutata dal governo italiano e dal
consorzio trentino dei comuni cosiddetti conquistati o liberati. La
ricostruzione avrà termine nel 1923-’24.
Col i patti di San Germano (1923) il comune di Livinallongo viene aggregato
alla provincia di Belluno.
Nel 1933 con decreto autografo di Benito Mussolini
viene aggiunto al nome del
comune la denominazione “del Col di Lana” che verrà confermato nel referendum
popolare comunale indetto dalla Regione Veneto nel 1983.

|
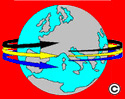
 Visita il
Visita il
 Visita il
Visita il
 Dopo le
invasioni barbariche, il territorio fu soggetto ai
Longobardi
e quindi ai
Franchi, fondatori del
Sacro Romano Impero. Con l'imperatore
Ottone I di Sassonia la zona dolomitica fu
ricompresa nella
Marca di Verona, a sua volta dipendente dal
ducato di Baviera prima e dal 975, sotto il controllo del Ducato di Carinzia.
Dopo le
invasioni barbariche, il territorio fu soggetto ai
Longobardi
e quindi ai
Franchi, fondatori del
Sacro Romano Impero. Con l'imperatore
Ottone I di Sassonia la zona dolomitica fu
ricompresa nella
Marca di Verona, a sua volta dipendente dal
ducato di Baviera prima e dal 975, sotto il controllo del Ducato di Carinzia.



 Il
Il  Il territorio di Livinallongo è limitato quasi interamente da confini naturali,
e precisamente: ad est le creste del Nuvolao lo dividono dalla Comunità di
Ampezzo, mentre i dirupi del Settsass e le lunghe giogaie del Pralongié dalla
Valle di S. Cassiano; ad ovest le alture di Sommamont e di Forcelle lo separano
dalla Valle di Corvara, mentre il gruppo del Sella ed il Sass Beccè da Gardena
e Fassa; a sud le lunghe vette della catena del Padon dalla Valle di Penia e
della Pettorina ed ad est il rivo di Davedino.
Il territorio di Livinallongo è limitato quasi interamente da confini naturali,
e precisamente: ad est le creste del Nuvolao lo dividono dalla Comunità di
Ampezzo, mentre i dirupi del Settsass e le lunghe giogaie del Pralongié dalla
Valle di S. Cassiano; ad ovest le alture di Sommamont e di Forcelle lo separano
dalla Valle di Corvara, mentre il gruppo del Sella ed il Sass Beccè da Gardena
e Fassa; a sud le lunghe vette della catena del Padon dalla Valle di Penia e
della Pettorina ed ad est il rivo di Davedino.
 Romani
sotto il comando di
Romani
sotto il comando di
 Il 2 aprile, alle 2 del pomeriggio, i valligiani dopo una strenua resistenza
stavano ormai ripiegando, quando una ragazza che era in servizio presso un
contadino di Spinges, uscì da una stalla, saltò oltre il muro del cimitero e
davanti alla porta della chiesa, armata di una forca, atterrò (forse spaventò
solo) alcuni soldati francesi, gli altri volsero in fuga. Quella ragazza era
Il 2 aprile, alle 2 del pomeriggio, i valligiani dopo una strenua resistenza
stavano ormai ripiegando, quando una ragazza che era in servizio presso un
contadino di Spinges, uscì da una stalla, saltò oltre il muro del cimitero e
davanti alla porta della chiesa, armata di una forca, atterrò (forse spaventò
solo) alcuni soldati francesi, gli altri volsero in fuga. Quella ragazza era


















 Il
Il 


 Nella prima sala sono rappresentati il sistema territoriale ladino, la
tipologia delle abitazioni, la gestione comunitaria, l’organizzazione civile,
religiosa e scolastica e la tipica strutturazione familiare ladina.
Nella prima sala sono rappresentati il sistema territoriale ladino, la
tipologia delle abitazioni, la gestione comunitaria, l’organizzazione civile,
religiosa e scolastica e la tipica strutturazione familiare ladina.











 ladina.
ladina.




